Lunedì 18 agosto 2025. Ciclo 8A: pembrolizumab 200 mg (1-21), gemcitabina 1700 mg, carboplatino 200 mg (1, 8-21). A corredo: antistaminici, antiemetici, gastroprotettori e corticosteroidi (Trimeton, Akinzeo, Pantorc, Soldesam). Durata complessiva dell’infusione: 4 ore.
Gli esami del sangue dicono che il mio corpo non sopporta più la chemio, ma in reparto si va avanti lo stesso perché «ci stiamo ancora dentro», lo dice il protocollo. Il protocollo dice anche che manca poco alla fine della chemioterapia: lunedì prossimo, il 25 agosto, se l’iniezione di Nivestim programmata per questo sabato farà risalire i globuli bianchi pungolando l’operosità del midollo osseo, sarà un’altra ultima chemio. L’immunoterapia con il pembrolizumab, invece, quella è prevista per un altro bel po’.
Ma, finita pure quest’altra chemio, che si fa? Forse la radioterapia, da ripetere più estesa e più massiccia come suggerito a Milano da Petrosjan, se i medici si metteranno d’accordo sulla sua presunta efficacia rispetto alla sua sicura tossicità per i polmoni. Forse qualche terapia di cui non abbiamo ancora parlato. Oppure finalmente si arrendono e mi lasciano crepare in pace. Ma poi: magari fosse davvero in pace.
Io me n’accorgo, quando mi si prepara tempesta.
Questa gran frase qui me l’ero annotata il 25 luglio. Infatti poi è arrivata tempesta.
La psichiatria li chiama “segnali anticipatori” e il paziente esperto, – voglio dire proprio: consumato, – s’allena a riconoscerli. Una crisi depressiva, un tracollo del tono dell’umore, un attacco di panico si annunciano come scricchiolii di un’architettura friabile.
Nel caso mio della malinconia atavica, eventualmente sollecitata dagli eventi esterni, dai “fattori ambientali”, – gli indizi dello sfacelo imminente si manifestano anche nel corpo, se uno sa vederli: le mascelle pesano, cascano, faticano a organizzare quella dozzina di muscoli che serve a sorridere.
Mi ricordo quelle di mia nonna Santina, di mascelle: quando mollavano la tenuta, il viso le diventava il muso di un vecchio cane San Bernardo. Collaboravano le code degli occhi, che s’appendevano all’ingiù. L’espressione complessiva era pensosa e afflitta.
Da mia nonna Santina ho ereditato la depressione endogena che mi alloggia nello “sbilico” quotidiano. Da mia zia Antonella che è viva, e da mia zia Morena che è morta da un sacco di anni, ho ereditato il cancro al seno che mi certifica nel regno dei pazienti oncologici.
Riassumo in me tutta una biologia di donne tribolate. Accettarlo.
Ho avuto due settimane di ferie. È stato quasi terribile.
Chi lavora in libera professione e ha una partita IVA non ha delle vere ferie, ma solo giorni in cui decide di non lavorare, e di non guadagnare. Sono tanti anni che vivo così. Ma quest’anno, oltre alle poche fatture emesse, ho anche una busta paga da dipendente: dice che svolgo un impiego part-time per trenta ore alla settimana e che ho diritto a ferie, malattie e permessi retribuiti. Ancora non m’abituo a questi benefici.
Ho iniziato questo nuovo lavoro a gennaio, in un ambiente e in un ruolo nei quali mi trovo a mio agio, e a luglio ho firmato un contratto a tempo indeterminato. Pure questo, oltre alle ferie retribuite, è la prima volta che mi accade. Pensavo che sarebbe stato un momento da festeggiare, quello della firma di un contratto a tempo indeterminato, invece no, non ne ho avuto voglia: il lutto, il lutto adesso sovrasta ogni cosa con il suo volume spesso violento. Oppure la mia natura rimane estranea al concetto di tempo indeterminato.
Anche Simone, lo scorso autunno, aveva firmato un contratto a tempo indeterminato come dipendente, dopo oltre vent’anni di partita IVA. Il 2 ottobre mi aveva mandato una foto in cui stringeva la mano a uno dei titolari dell’azienda per la quale già da tanto tempo lavorava come libero professionista. Nella foto era tutto sorridente. Sono fiera di te, gli avevo scritto.
Anche per Simone quest’estate sarebbe stata la prima con delle ferie vere.
Invece no, lui non gode più di niente. È morto il 13 giugno e questa è una lunga, odiosa estate. Odio il caldo, odio Ferragosto, odio la chemio, odio il port impiantato nel petto e odio le fiammate della menopausa causata dai farmaci, ma soprattutto odio che Simone non esiste più. Credo di averlo già scritto, qualche volta.
Durante queste due settimane di ferie ho rivisto amici che non vedevo da molto tempo.
Amici del mio vecchio tango, perciò amici in comune con Simone. S’è pianto, s’è riso, s’è mangiato e s’è bevuto. Con Giovanna s’è pure parlato di libri davanti al mare, e di questo le sono grata – ho ricominciato a leggere quelli di Davide Longo sulla serie di Bramard e Arcadipane, che amavo tanto. Fatico a concentrarmi come una volta, ma vado avanti.
Ho passato del tempo anche con gli amici di sempre, con i trasferiti che tornano per le feste, con familiari e parenti. Pranzi al mare, cene in campagna. Conversazioni prudenti, discorsi su responsabilità, rogne e minuzie del loro quotidiano (il lavoro, i figli, il caldo, il traffico, le vacanze, gli alberi da frutto). In pochi s’arrischiano a esplorare il mio quotidiano. Lo comprendo, ne ho tenerezza perfino.
Ho contezza, adesso, di qualche fatto semplice, secco, irrimediabile: che la portata della mia disperazione sotterranea è inaccessibile ai più. Che cogliere in profondità quello che succede a una persona che in due anni e mezzo vive due cancri e un lutto è possibile soltanto se in due anni e mezzo vivi due cancri e un lutto. Che certe esperienze possono allontanare e separare le persone in modo inesorabile. Non si può fare niente. È tutto.
Il primo giorno del resto della mia vita
Tra un paio di settimane farò la TAC di controllo e poi a settembre sarà il mio compleanno.
Compio 44 anni e, per il momento, non so che farmene della vita davanti, quella che eventualmente m’avanza. Nel suo libro L’anno del pensiero magico, Joan Didion individuava il primo giorno del resto della sua vita nell’atto di pulire il suo studio dopo la morte del marito John.
Nel testo, dopo una telefonata con la figlia Quintana in partenza per la California, scrive:
… andare in California sarebbe stato il primo giorno del resto della sua vita. Mentre riattaccavo mi venne l’idea che pulire il mio studio poteva essere un passo verso il primo giorno del resto della mia vita. Cominciai a farlo. E continuai così per la maggior parte del giorno seguente, giovedì 25 marzo. A momenti, durante quella tranquilla giornata, mi sorpresi a pensare che forse ero entrata in una nuova stagione.
Joan Didion, L’anno del pensiero magico, traduzione di Vincenzo Mantovani, Il Saggiatore, 2006, pp. 90-91.
Mi è venuto da pensare al primo giorno del resto della mia vita. Non è ancora arrivato, non mi pare. Quale potrebbe essere?
Io non credo che sarà quando sarò guarita un’altra volta dal cancro, se guarisco, né quando avrò finito un’altra volta tutte le terapie, se le finisco. Il primo giorno del resto della mia vita potrebbe essere quando mi metterò a pulire il mio, di studio, qui in questa casa dove mi sono ritirata; o quando ricomincerò a cucinarmi con cura piatti caldi e a mangiarli seduta al tavolo da pranzo ben apparecchiato invece che in piedi davanti al bancone della cucina, senza grazia, senz’attenzione. Oppure sarà quando la sera smetterò di pregare che Simone mi faccia visita in sogno (non lo fa, non mi visita. Se lo fa, al mattino non me lo ricordo. Perciò non lo vedo e non lo sento). Quando inizierò – si dice così, – a “lasciar andare”, come pare sappiano fare quelli che sanno vivere.
Oppure il primo giorno del resto della mia vita verrà quando, se mai, le mie guance, una volta sgonfiate dal cortisone, somiglieranno un po’ meno a quelle di mia nonna Santina, muso di San Bernardo addolorato.
Questo diario s’è impaludato, ristagna, non zampilla acqua fresca.
Ho letto un articolo del mese scorso su Il Nemico, la rivista di Gog Edizioni. Parla di narrativa pietista e un po’ ombelicale, che crea vittime facili facili da compatire e assolvere, dimenticando che “la letteratura dovrebbe essere soprattutto vita, invenzione, visione, tensione”. Anche quando al centro della narrazione ci sono malattia, trauma, perdita, ci si dovrebbe aspettare, dice, “trasfigurazione, non esposizione”. Io sono d’accordo (mentre non sono d’accordo con la lettura che viene fatta del libro di Alcide Pierantozzi, Lo sbilico).
A volte penso che dovrei smettere di scrivere per un po’. Altre volte penso che, se smetto adesso, allora è finita per davvero. Poi finalmente mi ricordo che questo diario qui è solo un blog, che il blog si chiama Progetto Kintsugi e che, stando ai dati, è letto da appena qualche centinaio di persone al mese. Sta nel suo, fa il suo, può ancora esistere, non è che un esercizio condiviso. Simone direbbe, avrebbe detto, di non smettere. Vediamo. Come mi dicono i medici: vediamo, Annalisa, vediamo.
[Immagine in copertina: NASA, Buzz Aldrin's Bootprint on the Moon for Apollo 11 Mission, from NASA CC0 Images, free for Canva]
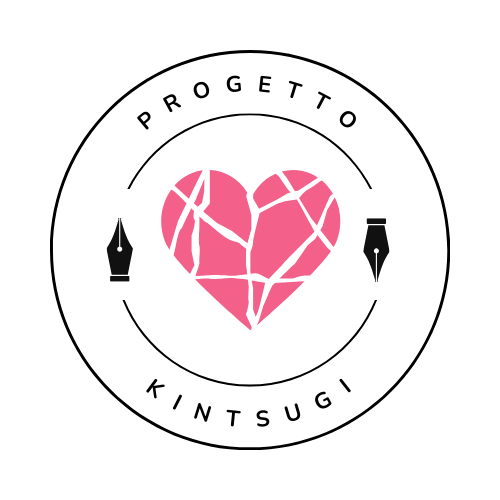

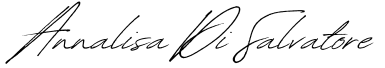



non smettere!
“Vediamo, Annalisa, vediamo”.
Non smettere, not yet.
“Vediamo, Annalisa, vediamo”.
Ho letto Lo sbilico e ho quindi voluto leggere anche l’articolo che hai citato, mamma mia che valutazione profondamente ingiusta. La scrittura è potentissima e il trauma, come lo chiamano ‘sti pijanculo qui, è doloroso anche per chi legge proprio perché è calato nel mondo che noi lettori abitiamo (scusa, forse non dovevo scrivere pijanculo sul tuo blog. Ops, due volte, scusa).
“Pijanculo” nel mio blog è parola densa e preziosa quanto lo “sbilico”!
Sì, la scrittura di Pierantozzi è potentissima, alle presentazioni del libro lui ripete che della letteratura non gliene frega niente e che l’ossessione per le parole non è che un sintomo del suo disturbo. Ma non mi convince.
L’autore dell’articolo sulla rivista di Gog Edizioni avvicina “Lo sbilico” di Pierantozzi a “Come d’aria” di Ada D’Adamo e, su scala globale, a “Una vita come tante” di Hanya Yanagihara: solo per quanto riguarda il secondo, questo sì che è un romanzo sulla vittima (ne ho scritto una volta qui: https://www.sfogliatine.blog/una-vita-come-tante/).
Grazie per il tuo passaggio qui.
A.
Annalisa vedi, vedi bene. La tua è letteratura ❤️
Barbara, grazie per la costanza con cui leggi quello che scrivo, qualunque cosa sia.
Smettere? Noooooo
“Vediamo, Annalisa, vediamo”.
Io ti seguo sempre, spero tu lo possa sentire.
Più che altro, lo posso vedere.
Grazie Sara!
Lascian andare, come quelli che sanno vivere. Eh già, io mi ci imbatto da una vita: come si fa a lasciar andare? Eppure per un gran pezzo della mia vita ho lasciato andare: non mi preoccupava tanto il futuro, non mi lasciavo lacerare dalla vita intorno. E’ invece questo un periodo in cui non riesco a farmi scivolare niente, nonostante io mi sia convinto che effettivamente il modo migliore è “lasciar andare”. Buon tutto. Ti seguo e ti leggo. Ho frequentato per poco Simone, e colpevolmente quando il gruppo di lettura si è sciolto me ne sono tornato alla mia vita. Ma evidentemente ha lasciato in me qualcosa, se sono qui a leggere questo blog, trovato risalendo come un salmone nella vita di Simone. Niente è per caso
Grazie per la tua lettura costante.
Simone ha lasciato qualcosa di buono nella vita di tutti quelli che ha incontrato.
Continua, Annalisa. Ti prego.
Vediamo.
Grazie per il tuo passaggio qui.
Tu scrivi e noi leggiamo .. non c’è niente da vedere … è così che deve andare!
Lineare.
Grazie per esserti palesata qui.